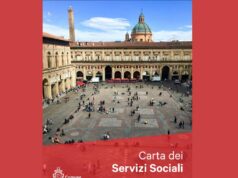La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con SCS
La Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, in collaborazione con SCS
Consulting e SWG, presenta i risultati dell’indagine ‘Casa, dolce casa?’ – condotta da Gianluigi Bovini, statistico e demografo – sulle esigenze abitative della popolazione over 59 nella Città metropolitana di Bologna, in risposta all’invecchiamento crescente della popolazione e alle sfide abitative emergenti.
Il XXI secolo sarà il secolo della longevità. Oggi, nella città metropolitana di Bologna quasi un cittadino su tre ha più di 59 anni. Lo scenario mediano delle previsioni demografiche Istat, disponibile per questo territorio fino al 1° gennaio 2050, evidenzia che tra venticinque anni gli over 59 potrebbero essere 412.656 (203.178 tra 60 e 74 anni e 209.478 sopra i 74) e la loro incidenza sul totale della popolazione salirebbe al 38,8%. Rispetto al 1° gennaio 2025 l’aumento di questo contingente sarebbe pari a 83.876 persone (14.148 in più tra 60 e 74 anni e 69.728 in più in età superiore a 74 anni).
Grazie a questa lunga durata della vita media il numero delle persone che entrano a fare parte della terza e quarta età aumenta sensibilmente in termini assoluti e si accentua anche il peso relativo di queste fasce sul totale dei residenti, a causa della contemporanea forte riduzione dei giovani.
È quindi importante essere consapevoli che, se oggi circa un cittadino metropolitano su tre si trova in questo contingente, tra venticinque anni nel territorio metropolitano bolognese tale condizione potrebbe riguardare quasi quattro persone ogni dieci. Aumenterebbe in particolare la presenza assoluta delle persone nella quarta età (74 anni e più), con un aumento dell’incidenza relativa dal 13,7% al 19,7% del totale dei residenti nella
città metropolitana di Bologna, stimati a quella data pari a 1.063.534.
Le conseguenze di questa evoluzione demografica sul mercato abitativo metropolitano sono di grande rilievo, tenuto conto anche dei dati relativi alla composizione dei nuclei familiari in questa fase della vita, che nella larga maggioranza dei casi sono formati da due persone o da un individuo che occupa da solo la propria abitazione. In altre parole, una situazione di potenziale solitudine abitativa riguarda ampie frazioni di anziani.
Già oggi, nella città metropolitana di Bologna il 35% del patrimonio abitativo è occupato da persone residenti, con all’interno degli alloggi la presenza sistematica solo di una o due persone con più di 59 anni; tra due decenni tale incidenza potrebbe salire a oltre il 40% degli appartamenti a disposizione dei cittadini metropolitani.
Sulla base di tali elementi appare importante indagare la condizione abitativa delle persone anziane, con particolare riferimento ad alcune situazioni strutturali dei fabbricati e delle abitazioni che possono incidere in maniera decisiva sulla qualità della vita. Molte ricerche evidenziano infatti che uno dei determinanti decisivi di una buona condizione di salute fisica e psichica è vivere in un contesto residenziale e in un alloggio adeguati ai bisogni e ai desideri delle diverse fasi della vita.
Nella società della longevità del XXI secolo il desiderio oggi largamente prevalente tra le persone in età superiore a 59 anni «voglio vivere il più a lungo possibile nell’abitazione in cui mi trovo» dovrebbe essere declinato: «Voglio vivere il più a lungo possibile in un’abitazione adeguata alle mie esigenze, per attraversare in buone condizioni di salute fisica e psichica la terza e quarta età della vita».
L’indagine
L’indagine è stata condotta con metodologia CATI nel mese di aprile 2025 e ha coinvolto 1.001 persone in età superiore a 59 anni (401 residenti a Bologna e 600 negli altri quarantaquattro comuni metropolitani coinvolti nell’indagine). Sulla base degli equilibri demografici registrati nella popolazione complessiva il 45% degli intervistati erano uomini e il 55% donne; il 57% aveva un’età compresa tra 60 e 74 anni (terza età) e il 43%
aveva più di 74 anni (quarta età). Ecco, in sintesi, i principali risultati dell’indagine.
La condizione familiare
Uno degli aspetti decisivi della transizione demografica è la profonda modifica delle forme familiari, che nella popolazione over 59 si manifesta nella presenza maggioritaria di nuclei composti da una sola persona o due persone. L’indagine ha evidenziato questo aspetto: nel campione di 1.001 intervistati la situazione più frequente è la convivenza con il/la partner (54%), seguita dalla condizione di solo/a (32%) e dalla convivenza con i figli (11%) o altri familiari (6%). La quota delle persone che vivono sole sale al 35% nel comune di Bologna e si attesta al 30% negli altri comuni metropolitani ed è più diffusa tra le donne (il 37% delle
intervistate si trova in questa situazione) rispetto agli uomini (27%). Significativo anche il dato che vede aumentare l’incidenza relativa delle persone sole al crescere dell’età: tale condizione si riscontra infatti nel 28% degli intervistati tra i 60 e i 74 anni e sale al 38% tra le persone con più di 74 anni.
Le tendenze abitative del presente
La grande maggioranza degli intervistati (74%) ha dichiarato di vivere in un’abitazione di proprietà del nucleo familiare senza mutuo a carico. Nell’11% dei casi veniva invece dichiarata un’abitazione di proprietà del nucleo familiare con mutuo a carico. Il 9% degli intervistati ha risposto di vivere in un’abitazione in affitto.
La cessione della nuda proprietà è una tendenza recente, segnalata in espansione: al momento ha interessa il 3% degli intervistati residenti a Bologna e solo l’1% negli altri comuni metropolitani. Un fattore importante per valutare la condizione abitativa, in relazione all’eventuale presenza di barriere architettoniche, è il piano in cui si trova l’abitazione: nel campione totale il 22% dichiara di abitare a piano terra e il 27% al piano rialzato o al primo piano. Quanto ai piani superiori la distribuzione è la seguente: 25%
ha dichiarato di abitare al secondo piano, il 14% al terzo piano, il 6% al quarto piano e infine il 6% in piani superiori al quarto.
Per quanto riguarda l’accessibilità dell’immobile, nel 45% dei casi è stata accertata la presenza di un ascensore e nel 10% di un montascale, mentre nel restante 45% non era presente nessuno dei due. Nel confronto territoriale la quota dei fabbricati privi di queste dotazioni era molto più alta negli altri comuni metropolitani (58%) rispetto a Bologna (30%).
Per quanto riguarda l’epoca di costruzione prevalgono nettamente gli immobili costruiti prima del 1980: sono il 75%, con la seguente scansione temporale: 12% costruiti prima del 1945, 26% tra il 1946 e il 1960 e 37% tra il 1961 e il 1980. Solo il 5% degli immobili è stato costruito dopo il 2000.
Per quanto riguarda la superficie dell’alloggio, emerge nettamente la tipologia degli appartamenti più ampi: il 27% di intervistati dichiara di vivere in alloggi con superficie tra 80 e 99 metri e il 36% sceglie la modalità «100 metri e oltre». Molto diffusa è anche la tipologia con superficie tra 60 e 79 mq (25% dei casi), mentre gli alloggi di minori dimensioni hanno incidenze nettamente più contenute (10% tra 40 e 59 metri quadrati e solo 2% meno di 40 metri quadrati).
L’indagine ha anche accertato la presenza di spazi esterni all’appartamento, con possibilità di più risposte: il 76% degli alloggi è fornito di balconi o terrazzi, nel 32% dei casi sono presenti spazi esterni o giardini a uso condominiale e nel 26% delle situazioni esistono spazi esterni o giardini a uso esclusivo. Solo nel 7% dei casi non sono presenti spazi esterni.
Alla domanda «da quanto tempo vive nel suo alloggio attuale» la larghissima maggioranza degli intervistati (85%) ha risposto «da più di 15 anni». Il restante 15% si suddivide nelle stesse proporzioni tra le altre tre modalità (da 11 a 15 anni, da 6 a 10 anni, fino a 5 anni), ognuna delle quali è stata indicata dal 5% degli intervistati.
La valutazione delle condizioni abitative
La percentuale di chi si è dichiarato «molto o abbastanza soddisfatto» è stata elevatissima nel giudizio sulla distribuzione degli spazi di casa (93%) e in quello relativo alla presenza di aree verdi nelle vicinanze dell’abitazione (92%). Giudizi sempre positivi, ma con minore intensità, sono stati espressi sulle relazioni sociali con amici e parenti (87% molto o abbastanza soddisfatti), sulla sicurezza della zona in cui si abita (86%), sulla distanza dell’abitazione dai servizi principali (85%) e infine sulla distanza dell’abitazione dalla
casa dei figli (82%).
Un quesito importante dell’indagine mirava ad accertare il giudizio degli intervistati sui costi di gestione e di locazione dell’alloggio. Il dato che emerge è la quota importante di chi li ha giudicati alti (30%) o molto alti (9%), mentre il restante 61% li ha ritenuti adeguati. Il dato su chi esprime giudizi preoccupati è sostanzialmente omogeneo tra chi risiede a Bologna (39%) e i cittadini degli altri comuni metropolitani (40%). Nella disaggregazione per età emerge una quota di chi esprime preoccupazione per i costi dell’alloggio più alta tra
gli intervistati tra 60 e 74 anni (41%) rispetto alle persone con più di 74 anni (38%).
In merito alle barriere architettoniche, nell’8% dei casi ne viene evidenziata la presenza all’interno dell’abitazione, nel 17% all’esterno e nel 10% in entrambe le situazioni. La quota delle condizioni giudicate critiche è più alta a Bologna (42%) rispetto agli altri comuni (31%) e si riscontra con maggiore frequenza tra gli intervistati in età da 60 a 74 anni (37%) rispetto a quelli con più di 74 anni (33%).
La valutazione della salute e dei bisogni di assistenza
Le valutazioni soggettive sullo stato di salute sono positive nel 64% dei casi, con una gradazione che va da ottima (7%) a molto buona (14%) e buona (43%); il 28% degli intervistati dichiara condizioni di salute discrete, mentre il restante 8% la giudica problematica o pessima.
Alla domanda sul bisogno di assistenza, la grande maggioranza degli intervistati (83%) dichiara di non avere bisogno di supporto. Il restante 17% si suddivide così: il 6% dichiara di «non essere pienamente autosufficiente e ho il supporto di altre persone», l’8% dichiara «sono autosufficiente, ma ho comunque il supporto di altre persone» e il 3% opta per «sono autosufficiente e avrei bisogno del supporto di altre persone». Il divario appare
inevitabilmente con il progredire dell’età (12% di chi dichiara il bisogno tra 60 e 74 anni e una quota doppia pari al 24% tra chi ha più di 74 anni).
Quando il supporto è presente le figure che lo prestano vengono così indicate: i figli (25%) il partner (12%), collaboratori familiari (9%), altri parenti (6%).
Le aspettative sulla condizione abitativa del futuro
In merito alle intenzioni di cambiare casa nei prossimi anni, la grande maggioranza degli intervistati (87%) risponde negativamente, mentre un 6% del campione si sta già attivando per cambiare o potrebbe pensarci nei prossimi anni. La propensione a cambiare casa è più elevata tra le persone da 60 a 74 anni (9%) rispetto a quelle con 75 anni e più (4%).
Gli intervistati sono stati inoltre interrogati sull’intenzione di realizzare nei prossimi cinque anni interventi di manutenzione straordinaria all’interno o all’esterno dell’alloggio. La modalità nettamente prevalente (otto casi su dieci) è quella di chi dichiara di non prevedere alcun intervento. Tra chi ha risposto positivamente le modalità più indicate sono le seguenti: interventi per migliorare l’efficienza energetica, interventi di rifacimento strutturali (es: rifacimento tetto o miglioramento della sicurezza sismica), interventi per il
superamento delle barriere architettoniche interne all’appartamento, montaggio di ascensori o montascale.
Il questionario si chiude con una domanda volta ad accertare l’interesse degli intervistati su soluzioni abitative innovative. Il 21% degli intervistati dichiara di essere molto o abbastanza interessato a soluzioni di coabitazione (senior housing o cohousing) con altre persone in strutture che forniscono servizi primari, abitativi e legati al tempo libero. Il 20% ha invece manifestato interesse verso soluzioni di condivisione dei propri spazi abitativi con altre persone che non fanno parte del proprio nucleo familiare o della propria cerchia
ristretta in un’ottica di reciproco aiuto. In entrambi i casi l’interesse verso queste soluzioni innovative era più elevato tra gli intervistati in età da 60 a 74 anni.
Di particolare rilievo per le tematiche affrontate nell’indagine sono infine le seguenti considerazioni contenute in un report dell’ Istat: «Il vivere soli, una condizione spesso involontaria, nel caso delle persone anziane può condizionare la qualità della vita, soprattutto quando crescono le limitazioni nelle attività quotidiane. Se, infatti, per gli individui di 65 anni o più diventa sempre meno frequente riscontrare limitazioni alle capacità funzionali, ben diversa è la situazione al superamento di una soglia di età pari a 75 anni, più soggetta a bisogni specifici e fragilità legate all’invecchiamento. Il numero di ultrasettantacinquenni che potrebbero vivere da soli, in particolare, è destinato a salire di oltre 1,7 milioni (di cui 1,2 milioni di donne) nel 2050, raggiungendo la cifra assoluta di 4,6 milioni di individui soli (di cui 3,4 milioni di donne)».
Conclusioni
Con riferimento ai temi affrontati nell’indagine promossa dalla Fondazione del Monte gli elementi più significativi sono: il forte aumento delle persone in età superiore ai 59 anni che vivranno sole, condizione che nelle età più avanzate riguarderà in particolare le donne; la crescita delle persone che nel corso della loro vita non avranno avuto figli e conviveranno solamente con il/la partner. Tra le persone che invece hanno avuto figli, in considerazione delle attuali tendenze del mercato del lavoro, potrebbe infine crescere la quota di chi si
troverà ad abitare a una distanza significativa, che renderà molto difficili relazioni di mutuo aiuto e supporto sistematiche.
A questi mutamenti demografici e sociali si accompagneranno trasformazioni, più difficili da prevedere, nella condizione economica delle persone che si trovano nella terza e quarta età, legate in primo luogo nel medio e lungo periodo alle dinamiche del mercato del lavoro e del sistema previdenziale e ai mutamenti dei valori del patrimonio immobiliare, oggi largamente concentrato nelle fasce di età più avanzate. Confrontarsi con questi
possibili, e in alcuni casi molto probabili, scenari di mutamento è fondamentale per tentare di comprendere come potrebbero evolvere nei prossimi decenni alcuni elementi della condizione abitativa della terza e quarta età messi in luce dall’indagine campionaria.
I punti di forza presenti nella situazione attuale sono un’elevata quota di abitazioni possedute in proprietà e superfici medie degli alloggi elevate, che consentono alla maggioranza degli intervistatati di esprimere un giudizio di soddisfazione su molti aspetti della condizione abitativa e motivano la preferenza largamente prevalente di volere continuare a vivere in quell’abitazione. Non bisogna però ignorare alcuni elementi di
criticità, rappresentati da un’alta età media di costruzione dei fabbricati, da costi di gestione/manutenzione straordinaria degli alloggi giudicati in una quota non trascurabile dei casi molto elevati, da una diffusa e persistente presenza di barriere architettoniche e dalla collocazione dell’abitazione in contesti residenziali non urbani privi di una rete diffusa dei servizi di prossimità essenziali.